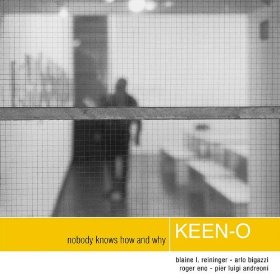Dopo Experiments in Ambient Soul, che ha raccolto ottimi riscontri in vari club sparsi qua e là per il mondo, Stefano Ghittoni e Cesare Malfatti ritornano con Ink, nuovo sorprendente lavoro in studio, dove recuperano sonorità cinematiche e minimaliste degli esordi. Un quinto album che guarda al passato con la maturità del presente.
“Nemo propheta in patria”. È questo il destino di molti artisti italiani apprezzati e valorizzati più all’estero che non nella loro terra natia. Le ragioni possono essere le più varie: o perché viene instaurato un certo feeling con una particolare audience, o l’estetica sonora e le tematiche proposte trovano maggiore riscontro in determinati ambienti, o semplicemente perché taluni musicisti sviluppano – senza scendere a facili compromessi legati al business – un percorso peculiare e originale che in qualche modo spiazza il pubblico nostrano. Questi elementi in parte spiegano il motivo per cui The Dining Rooms, uno dei progetti più interessanti made in Italy legato al mondo dell’elettronica creato da Stefano Ghittoni e Cesare Malfatti, ottenga maggiori riconoscimenti in Paesi come la Francia o gli States. In realtà, nel loro caso, questa sorte non stupisce più di tanto.
 Nelle loro produzioni si respira infatti una forte essenza cosmopolita, che travalica frontiere, luoghi comuni e sonorità prevedibili. Lo hanno dimostrato sin dagli esordi con Subterranean Modern Volume 1, uscito nel 1999 pervaso da ritmi funk e hip hop a cui si aggiungono intimistiche, a tratti struggenti atmosfere blues. Un disco totalmente strumentale in quanto The Dining Rooms, almeno in una prima fase, hanno privilegiato le sperimentazioni sonore escludendo la parte vocale. Cesare (tra i fondatori dei La Crus) e Stefano (noto DJ, nonché artefice di vari progetti tra cui Double Beat), quando hanno deciso alla fine degli anni ’90 di iniziare a lavorare seriamente insieme, avevano in comune la vecchia passione per il punk e la new wave, generi che per loro hanno rappresentato un importante background da cui attingere fascinazioni e spunti legati all’aspetto strumentale delle composizioni. Coi successivi album, il duo residente a Milano ha iniziato a circondarsi di ottimi vocalist, come Marta Collica, Anna Clementi e Sean Martin, non solo interpreti, ma anche autori delle liriche. I testi, mai cantati in italiano, e l’elegante architettura musicale fondata su un tappeto elettronico hanno permesso ai Dining Rooms di farsi conoscere in Europa, oltre oceano e in Giappone, grazie a brani come “You”, “Il girotondo dei grandi” (pezzo strumentale ma altamente evocativo), “Destination moon” e “Tunnel” (uno dei loro masterpiece). Pur riconoscendo un filo conduttore che lega le loro produzioni, ogni lavoro esprime un peculiare paesaggio sonoro attraverso cui vengono sviscerate suggestioni artistico-esistenziali. Reminescenze afro, rimandi a pellicole e colonne sonore d’autore, echi cinematici s’incontrano nel loro terzo album, non a caso intitolato Tre, cui segue Experiments in Ambient Soul (2005) che conferma definitivamente le loro capacità nel forgiare una musica elettronica in cui pulsano emozioni introspettive. Cesare e Stefano vengono invitati a suonare in varie location prestigiose sparse qua e là per il mondo, da Parigi a Mosca, ma nel frattempo il loro fermento creativo non si arresta, non ripetono mai le stesse sequenze, la stessa “formula”, gli stessi beat. E lo hanno dimostrato ancora una volta con Ink (Schema Records), un quinto album che porta con sé la consapevolezza della maturità artistica, ma che ha una prospettiva originale frutto dell’incontro tra gli influssi dark-minimalisti e raffinate atmosfere orientate all’elettro-jazz. Si avverte un maggiore equilibrio fra composizioni interpretate da ottimi vocalist (Toco, Renaud Chauré, Georgeanne Kalweit, Dodo, Sean Martin) e pezzi strumentali dove risaltano le chitarre elettriche rhodes di Marco Rigamonti, Don Freeman e Patrick Benifei. Non mancano inoltre riferimenti all’arte e alla vita reale. Fra le tracce più rappresentative segnaliamo “Thank You?”, oscillante tra ritmi rock-funk e nuance soul della migliore tradizione afro-americana, e “Free to grow”, avvolta da struggenti e coinvolgenti arrangiamenti creati dal meraviglioso intreccio tra basso (Marcello Testa), chitarre e drums (Leziero Rescigno). Oltre alla dimensione strettamente musicale, s’incontrano rimandi al teatro e al cinema. Emblematica in questo senso è “Etage noir 1”, dove la voce di Renaud Chauré (uno degli attori dell’Associazione teatrale Motus ) accompagna ipnotiche e oscure onde sonore. “C’è un recupero di sfumature tipiche dei nostri esordi”– ci raccontano tra le pareti tecnologiche dello Studio CHE. “Abbiamo ripreso certe sonorità blues e taluni elementi cinematici, anche se di fatto questi suoni hanno sempre accompagnato il nostro percorso artistico. Si ritrovano per esempio in Experiments in Ambient Soul che però consideriamo un album più pop rispetto a Ink, dove invece abbiamo voluto [ri]-creare atmosfere più intimistiche, attraverso l’uso preponderante della chitarra elettrica. È anche un disco molto più strumentale rispetto al precedente dove c’erano svariati pezzi vocali”.
Nelle loro produzioni si respira infatti una forte essenza cosmopolita, che travalica frontiere, luoghi comuni e sonorità prevedibili. Lo hanno dimostrato sin dagli esordi con Subterranean Modern Volume 1, uscito nel 1999 pervaso da ritmi funk e hip hop a cui si aggiungono intimistiche, a tratti struggenti atmosfere blues. Un disco totalmente strumentale in quanto The Dining Rooms, almeno in una prima fase, hanno privilegiato le sperimentazioni sonore escludendo la parte vocale. Cesare (tra i fondatori dei La Crus) e Stefano (noto DJ, nonché artefice di vari progetti tra cui Double Beat), quando hanno deciso alla fine degli anni ’90 di iniziare a lavorare seriamente insieme, avevano in comune la vecchia passione per il punk e la new wave, generi che per loro hanno rappresentato un importante background da cui attingere fascinazioni e spunti legati all’aspetto strumentale delle composizioni. Coi successivi album, il duo residente a Milano ha iniziato a circondarsi di ottimi vocalist, come Marta Collica, Anna Clementi e Sean Martin, non solo interpreti, ma anche autori delle liriche. I testi, mai cantati in italiano, e l’elegante architettura musicale fondata su un tappeto elettronico hanno permesso ai Dining Rooms di farsi conoscere in Europa, oltre oceano e in Giappone, grazie a brani come “You”, “Il girotondo dei grandi” (pezzo strumentale ma altamente evocativo), “Destination moon” e “Tunnel” (uno dei loro masterpiece). Pur riconoscendo un filo conduttore che lega le loro produzioni, ogni lavoro esprime un peculiare paesaggio sonoro attraverso cui vengono sviscerate suggestioni artistico-esistenziali. Reminescenze afro, rimandi a pellicole e colonne sonore d’autore, echi cinematici s’incontrano nel loro terzo album, non a caso intitolato Tre, cui segue Experiments in Ambient Soul (2005) che conferma definitivamente le loro capacità nel forgiare una musica elettronica in cui pulsano emozioni introspettive. Cesare e Stefano vengono invitati a suonare in varie location prestigiose sparse qua e là per il mondo, da Parigi a Mosca, ma nel frattempo il loro fermento creativo non si arresta, non ripetono mai le stesse sequenze, la stessa “formula”, gli stessi beat. E lo hanno dimostrato ancora una volta con Ink (Schema Records), un quinto album che porta con sé la consapevolezza della maturità artistica, ma che ha una prospettiva originale frutto dell’incontro tra gli influssi dark-minimalisti e raffinate atmosfere orientate all’elettro-jazz. Si avverte un maggiore equilibrio fra composizioni interpretate da ottimi vocalist (Toco, Renaud Chauré, Georgeanne Kalweit, Dodo, Sean Martin) e pezzi strumentali dove risaltano le chitarre elettriche rhodes di Marco Rigamonti, Don Freeman e Patrick Benifei. Non mancano inoltre riferimenti all’arte e alla vita reale. Fra le tracce più rappresentative segnaliamo “Thank You?”, oscillante tra ritmi rock-funk e nuance soul della migliore tradizione afro-americana, e “Free to grow”, avvolta da struggenti e coinvolgenti arrangiamenti creati dal meraviglioso intreccio tra basso (Marcello Testa), chitarre e drums (Leziero Rescigno). Oltre alla dimensione strettamente musicale, s’incontrano rimandi al teatro e al cinema. Emblematica in questo senso è “Etage noir 1”, dove la voce di Renaud Chauré (uno degli attori dell’Associazione teatrale Motus ) accompagna ipnotiche e oscure onde sonore. “C’è un recupero di sfumature tipiche dei nostri esordi”– ci raccontano tra le pareti tecnologiche dello Studio CHE. “Abbiamo ripreso certe sonorità blues e taluni elementi cinematici, anche se di fatto questi suoni hanno sempre accompagnato il nostro percorso artistico. Si ritrovano per esempio in Experiments in Ambient Soul che però consideriamo un album più pop rispetto a Ink, dove invece abbiamo voluto [ri]-creare atmosfere più intimistiche, attraverso l’uso preponderante della chitarra elettrica. È anche un disco molto più strumentale rispetto al precedente dove c’erano svariati pezzi vocali”.
Voi in effetti nascete come gruppo strumentale…
“Assolutamente. In Subterranean Modern Volume 1 non c’erano brani cantati. Poi, pian piano abbiamo inserito le liriche, sino a giungere ad Experiments in Ambient Soul dove abbiamo dato molto spazio ai vocalist e ai testi da loro concepiti. Proprio Experiments in Ambient Soul pensavamo aprisse una nuova fase del nostro percorso. In realtà, ci siamo accorti che era l’estrema conclusione della prima. È come se avessimo sentito l’esigenza di ripartire quasi da capo. Ink si avvicina alle tematiche originarie dei Dining rooms però è anche un disco realizzato con la consapevolezza maturata negli anni, con una qualità produttiva molto più alta”.
Le varie tracce sono nate in diversi momenti o hanno seguito un preciso percorso concettuale?
“Questo album, come del resto tutte le nostre produzioni, esprime e rappresenta un particolare periodo. Quando lavoriamo in studio, chiaramente portiamo anche il nostro vissuto, le nostre passioni, ciò che ci capita all’esterno. Ogni traccia ha una sua storia e Ink da un certo punto di vista è un concept album sviluppato in una precisa fase del nostro viaggio artistico”.
Qual è il rapporto tra il vostro lavoro di programmazione e l’approccio che instaurate con i vari vocalist?
“In studio ci basiamo sui sample, che sviluppiamo poi con la programmazione, a cui aggiungiamo i vari strumenti e qualche altro campione. Essendo noi un gruppo elettronico non componiamo con chitarra e voce. C’è un modo di scrivere particolare e in questo modo di scrivere a volte entrano campionamenti vocali che danno per certi versi un alone di melodia. Capita poi che frammenti di voce forniscano lo spunto per la costruzione del pezzo stesso.
Con i cantanti noi interveniamo dal punto di vista della produzione, raramente per quanto riguarda le liriche, anche perché lavoriamo quasi sempre con vocalist di madrelingua inglese e in questo disco anche francese e portoghese. Con i cantanti abbiamo un approccio molto libero. Noi sviluppiamo la parte strumentale, scegliamo la persona che deve interpretare il brano e generalmente il testo nasce dalla fantasia e dalla sensibilità del vocalist stesso. Certo, valutiamo le singole tematiche, ma in generale c’è molta libertà e sintonia tra noi e i cantanti che lavorano a nostro fianco”.
Nella vostra musica sono evidenti forti rimandi all’arte, non solo attraverso i video firmati da Maria Arena, ma anche per varie citazioni. Esemplare in questo senso è l’ultima traccia di Experiments in Ambient Souldove vengono sviscerati nomi di registi, scrittori, musicisti che più vi hanno influenzato. Nel nuovo disco, avete coinvolto l’attore francese Renaud Chauré, e una traccia, “On the beach” vi è stata ispirata da un dipinto di Picasso. C’è da parte vostra questa consapevolezza di inserire volutamente nella musica riferimenti ad altri linguaggi estetici?
“Questa consapevolezza è indubbiamente reale sin dagli inizi. Nel primo disco, la copertina è ispirata a Soultrain di Coltraine. Nei testi o nei frammenti di testi amiamo inserire particolari citazioni soprattutto legate alla beat generation, che è uno dei nostri punti di riferimento culturali. Aggiungiamo spesso anche una serie di rimandi a situazioni politiche, il tutto secondo una certa visione esistenziale legata alla fine degli anni ’60, inizio ’70. Poi cerchiamo di stare attenti alle pulsioni che si sviluppano attorno a noi. I titoli di alcune tracce incluse in Ink sono ispirati a romanzi. “Fatale” si rifà al testo di Jean-Patrick Manchette, romanziere francese, inventore del polar, un genere letterario noir crudo, molto tarantiniano, mentre “Appuntamento a Trieste” si riferisce chiaramente a Scerbanenco che già avevamo citato in altri lavori. La copertina di Ink è invece ispirata all’arte di Basquiat. Questi riferimenti sono un po’ una sorta di mosaico delle nostre passioni che introduciamo nella musica. Il mondo che ci sta intorno inevitabilmente si manifesta e si insinua in tutto ciò che realizziamo. Abbiamo sempre cercato di esprimere una certa filosofia di vita e quindi di segnalare uno stile in cui qualcuno si possa riconoscere. Si cresce dal punto di vista tecnico-compositivo, ma le pulsioni iniziali rimangono. Quello che una persona è, poi alla fine lo esprime e lo mette in tutto ciò che fa. E questo nostro atteggiamento ha in sé una sua coerenza. Non seguiamo mode, onde musicali fugaci ed è per questo che siamo riusciti a creare uno stile che ci appartiene”.
Vi siete sempre circondati da ottimi musicisti e vocalist, dal sudafricano Sean Martin al brasiliano Toco. Anche nello scegliere le persone con cui lavorate si percepisce la volontà di travalicare le ristrette frontiere italiane…
“Ci siamo sempre rivolti sin dall’inizio a una scena internazionale. Negli ultimi anni abbiamo suonato in varie città, tra cui Amsterdam, Seoul, Mosca e Parigi. È importante per noi avere una credibilità all’estero, per cui il cantante deve essere sempre di madrelingua, dato che vogliamo dare al nostro lavoro una visione internazionale, che in fondo rispecchia la nostra stessa essenza. Collaborare con artisti stranieri ci arricchisce enormemente e dà origine a interessanti idee, come “Cobra Coral” cantata da Toco, finora unica traccia Brazilian noir del nostro repertorio…”.
Vi sembra che la scena elettronica italiana negli ultimi anni stia vivendo una sorta di rinascita?
“Secondo noi non si può parlare di una vera e propria scena elettronica italiana. In realtà, pensiamo che il concetto di scena musicale sia più una costruzione mediatica artificiosa. Certo, le situazioni e gli approcci differiscono. La Francia è un Paese dove le cose possono succedere, c’è più coraggio per determinate scelte. In Italia, sì… è possibile alimentare nuove situazioni, ma riteniamo sia più complicato nutrire e sostenere determinate realtà “alternative” come è il caso della musica elettronica soprattutto non commerciale. Vogliamo però sottolineare che rispetto ai nostri inizi, oggi il fare elettronica è molto più semplice. Con lo sviluppo tecnologico-digitale ovunque è possibile creare musica, dallo scantinato di casa agli slum nelle periferie urbane. Ovviamente il livello qualitativo cambia, ma quello che conta è che ci sono molte più possibilità e libertà nel comporre elettronica”.
Intervista di Silvia C. Turrin© anche in formato pdf THE DINING ROOMS