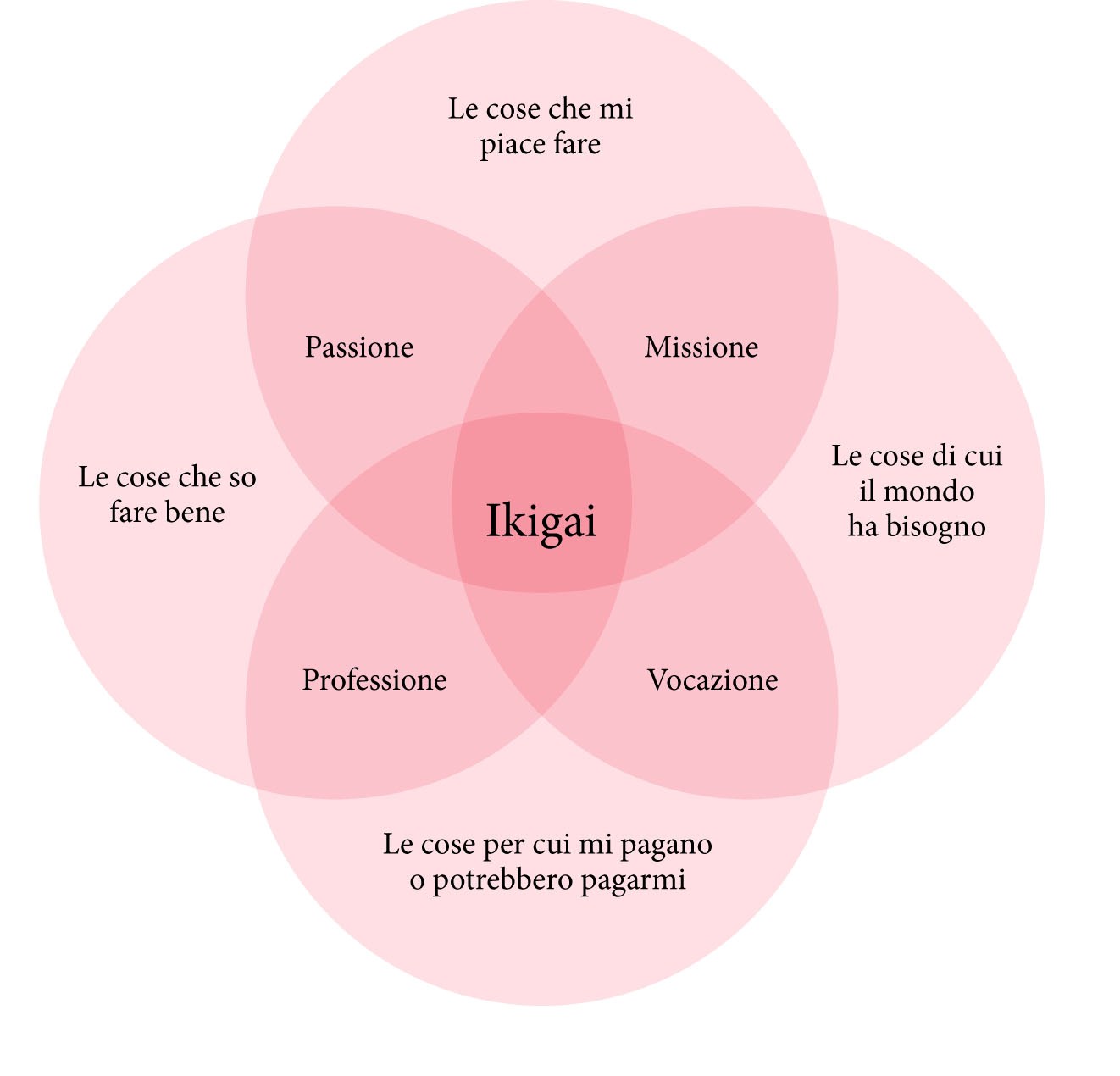Il 74° Festival del Cinema di Berlino ha visto al centro l’Africa, per vari motivi.
Innanzitutto, a presiedere la giuria è stata Lupita Nyong’o, attrice e regista, con doppia cittadinanza messicana e keniota. Classe 1983, Lupita è nata in Messico, quando suo padre, Peter Anyang’ Nyong’o – oggi segretario generale del partito Orange Democratic Movement – insegnava come professore presso un collegio locale.
I genitori kenioti ritornarono nel loro paese d’origine quando Lupita aveva appena un anno ed è a Nairobi che ha iniziato ad appassionarsi di cinema. Gli studi presso l’Hampshire College di Amherst (Massachusetts, USA) e la specializzazione alla Yale School of Drama le hanno aperto le porte a Hollywood.
Un debutto impegnato (a cominciare dai documentari da lei firmati, tra cui quello incentrato sui pregiudizi in Kenya verso gli albini), suggellato dall’Oscar alla miglior attrice non protagonista per l’interpretazione della schiava Patsey nel film “12 anni schiavo”. Seguono ruoli nella saga di successo Star Wars e in Black Panther.
Lupita Nyong’o è la prima africana ad aver presieduto la giuria internazionale della Berlinale.
E a ricevere l’Orso d’Oro come miglior film nell’edizione 2024 è stata un’altra donna con radici africane, la regista franco-senegalese Mati Diop, grazie al lungometraggio “Dahomey”.
Un documentario che parla ancora di Africa, quella del passato e quella contemporanea. In questo film Mati Diop racconta la storia della restituzione, avvenuta nel novembre 2021, di 26 tesori reali al Benin da parte della Francia. Tesori saccheggiati dalle truppe francesi nel 1892, quando all’epoca il Benin – l’allora Dahomey – era una colonia di Parigi.
“Possiamo dimenticare il passato, un peso spiacevole che ci impedisce di evolvere, oppure possiamo assumercene la responsabilità, e usarlo per evolvere”, ha dichiarato la regista Mati Diop nel ricevere il premio alla Berlinale.
Quello di Mati Diop è un documentario impegnato e originale, che riporta alla luce il periodo coloniale in Benin attraverso la voce narrante della statua antropomorfa del re Ghezo, che regnò sul Dahomey dal 1818 al 1858. Fu questo sovrano a ristabilire la pace civile nel regno.
Nel documentario, la voce del re Ghezo, in Fon (la lingua del Benin), deplora il fatto di essere ricordato solo con un numero, il “26”, e non con il suo nome, all’interno del museo Quai Branly a Parigi.
Parlando di questo spazio museale francese, occorre aprire qui una breve parentesi.
Negli anni recenti si è aperto un dibattito sulla rappresentazione dei popoli extra-europei attraverso il loro patrimonio culturale portato nel Vecchio Continente durante il periodo coloniale e racchiuso, appunto, nei musei.
Per questo, molti si pongono questa domanda: le culture “altre” sono rappresentate, spiegate e narrate nei musei dal punto di vista dei colonizzatori?
Questo dibattito si collega al tema centrale del documentario di Mati Diop, ovvero la restituzione dei beni artistico-culturali ai loro rispettivi Paesi d’origine. In questo caso, parliamo del Benin.
In fondo, è proprio la necessità di essere rappresentato in modo veritiero, che spinge il re Ghezo a sottolineare, nel film, l’esilio forzato dalla sua terra natia e il desiderio di ritornarvi per ritrovare la sua identità.
La Berlinale, consegnando l’Orso d’Oro a Mati Diop, ha messo al centro il tema del colonialismo e delle sue conseguenze ancora oggi visibili non solo in ambito storico-culturale.
Silvia C. Turrin